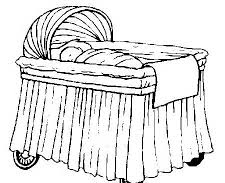mamarAdmin
mamarAdmin- Messaggi : 1089
Data di iscrizione : 01.11.22
Località : l'isola che non c'è
 Racconti siciliani : Luigi Natoli - La parricida
Racconti siciliani : Luigi Natoli - La parricida
Dom 7 Apr 2024 - 19:11
Fontanazza aspettava nell’ombra, sotto l’arco del campanile di San Francesco.
La notte era bella e luminosa. La luna diffondeva nel cielo un biancore che faceva impallidire le stelle e rischiarava una parte della vasta piazza silenziosa e deserta. L’arco del campanile restava immerso nell’ombra: chi vi si nascondeva non poteva esser veduto.
Il silenzio era profondo. Ma dagli orti e dai campi vicini giungeva il canto delle cicale, il trillo malinconico dei rospi. Un orologio suonò la mezzanotte.
Fontanazza rabbrividì e si guardò intorno.
No, non veniva nessuno ancora. E, per quanto egli tendesse l’orecchio, non s’udiva alcun rumore di passi.
Eppure a quell’ora tutto doveva essere avvenuto. Ella aveva promesso il colpo, verso tre ore di notte, quando tutto il palazzo si sarebbe sprofondato nel sonno. Aveva già preparato un sacco con la roba più necessaria. Non doveva che ammassare le gioie, l’argenteria e il denaro che eran nello stipo dentro la camera della vecchia… Per far questo sarebbe bastato un quarto d’ora… E intanto ne eran passati parecchi quarti d’ora… Che cosa dunque era accaduto?
Pian piano uscì dall’ombra, varcò la soglia dell’arco, scese i gradini, poi mosse alcuni passi, lenti, guardinghi, nella piazza, guardando in fondo, dalla parte dalla quale doveva venir lei; e a poco a poco attraversò la piazza, imboccò la strada buia che gli si apriva dinanzi, sempre più stupito di non veder nessuno.
Cominciava a disperare, quando udì un calpestio frettoloso che s’andava avvicinando e, indi a non molto, distinse nell’ombra una figura di donna che pareva curva sotto un peso.
La riconobbe, le mosse incontro.
La donna ebbe un gesto di sgomento e fece per fuggire, ma Fontanazza le disse:
– Son io, non aver paura… Da’ a me.
Le tolse di dosso un sacco e, ripresa la via del ritorno, soggiunse:
– Presto!… Ho nascosta la mula fuori porta Palermo.
La donna disse ansimando:
– Ma la porta sarà chiusa!…
– Non aver paura. Apriranno… Ho già disposto le cose…
Si affrettarono senza dir più nulla. Egli innanzi, lei dietro, tutta chiusa nel manto che ora, avendo libere le braccia, aveva accomodato sul capo e teneva stretto con le mani.
La porta era serrata con una grossa stanga di legno che si tirava. I gabellieri dormivano in un casotto accanto. Uno di essi si era sdraiato sopra una panchetta, accanto alla porta, e sonnecchiava. Fontanazza lo destò scotendolo e mormorandogli all’orecchio:
– Ohè, compare, aprite dunque.
– Ehm!… Siete voi? Eccomi.
La donna chiuse ancor più il manto, in modo da coprire il viso, nel passar davanti il gabelliere.
Camminarono una ventina di passi e trovarono la mula legata a un albero.
Le caricarono il sacco. Fontanazza aiutò la donna a montare in sella e, prese le redini in mano, cominciò a scendere dal colle.
La luna illuminava il vasto anfiteatro di colli e di monti che circondavano l’altipiano di Castrogiovanni e tra i quali, solitario, acuto, spiccava il monte di Calascibetta, come un gigante posto a vigilare l’antica Enna.
A mezza costa, Fontanazza prese un viottolo che si internava fra le macchie e, dopo poco, giunse a una casetta. Legò la mula a un piolo infisso nel muro. Aiutò la donna a scavalcare e, preso il sacco, entrarono.
Fontanazza accese una lucernetta preparata sopra una tavola, indi andò a sprangare la porta e, voltosi alla donna, le disse:
– Levati il manto e siedi.
Ella si lasciò cadere sopra la sedia e buttò il manto indietro. La lucerna la illuminava: era una donna d’una trentina di anni, non bella ma piacente, pallida, con una grande ruga fra le sopracciglia, un fremito nelle narici di belva, una fosca nube sugli occhi.
Fontanazza la guardò un attimo. Le vide le mani e gridò con stupore e raccapriccio:
– Del sangue? Hai del sangue nelle mani?
Allora la donna si guardò le mani aperte e le vide rosseggiare. E allora fu scossa da un brivido e una espressione di orrore alterò il suo volto.
Fontanazza ripeté:
– Del sangue!… Che hai dunque fatto?…
Ella non rispose.
– L’hai dunque uccisa?
– Sì – mormorò essa con un soffio di voce. E poco dopo aggiunse:
– Era necessario.
Rimasero un poco in silenzio, seduti, in faccia l’un dell’altro, illuminati dalla lucerna, in quella misera casupola campestre, col sacco sulla tavola.
Qualche cosa passava fra loro, invisibile ma agghiacciante. E pure avevano da tempo accarezzato il sogno di quella fuga, per vivere lontani, soli, l’uno dell’altro. Vivere della loro passione, di quella passione che aveva colmato l’abisso sociale che li separava, che aveva lacerato doveri, calpestato sentimenti e che ora tingeva fatalmente di sangue le mani di uno di loro.
Che cosa era egli, Giuseppe Fontanazza? Un paggio, un servo. Fino a quel giorno stesso egli aveva prestato i suoi servizi e, al cospetto di tutti, aveva dato dell’eccellenza alla donna che ora, a solo, trattava del tu e gli si piegava dinanzi quasi tremando. Fino a quel giorno ella, la nobile donna Giuseppina Guzzardi di Adernò, maritata a un Rametta, in Castrogiovanni, era stata per tutti la sua padrona. Da qualche mese, occultamente, era la sua amante.
Forse, in quel momento di silenzio e di terrore, la memoria si ridestava e tutto il passato, tutte le vicende della colpa ritornavano con vivace crudezza ai loro occhi interiori.
Ella non era giovane. Si avvicinava forse alla quarantina. Bruna, con gli occhi neri e cupi, la fronte bassa, la mascella forte, la bocca sensuale.
Aveva una bellezza belluina. Il suo corpo aveva la mollidezza e la flessibilità dei felini. Il suo petto pareva si offrisse.
Fontanazza era più giovane. Aveva fattezze comuni e l’aria sfrontata. Ma robusto, forte, un torello.
Ella si era accesa dalla voglia di quel torello. E una mattina che il marito era andato in campagna di buon’ora ed ella, levatasi per aiutarlo, l’aveva accompagnato fin sulla porta, come soleva fare, quando l’ebbe visto allontanarsi a cavallo, rientrò e serrò l’uscio; veduto dietro a lei Fontanazza, in maniche di camicia, col petto velloso e muscoloso, lo spinse dietro la pagliaia.
Così, Fontanazza il servo diventò il suo padrone. Egli la signoreggiò, ma era vile e aveva paura. Aveva paura del suo padrone, ma soprattutto della vecchia dama Spitaleri, la nonna di Giuseppina. Era una donna ancor vegeta e vitale, non ostante i suoi ottant’anni; con la mente lucida e i costumi rigidi. Ella teneva veramente il governo della casa. La figlia e il genero gliel’avevano lasciato. Morti essi, la nipote Giuseppina, seguendo la consuetudine, non aveva creduto di toglierle quel governo che la vecchia dama teneva così nobilmente e saviamente.
La nonna Spitaleri era sempre in giro per la casa. Dritta, segaligna, rugosa, vestita di nero alla moda della sua giovinezza, col mazzo delle chiavi alla cintola. Sorvegliava la servitù, distribuiva il pane agli uomini, il lino alle donne di casa, teneva i conti col suo razionale e segnava i crediti in pezzi di ferula, ognuno dei quali rappresentava una partita.
Oh, era inflessibile, la vecchia dama, contro gli oziosi e i sornioni.
Fontanazza lo sapeva. Una mattina la nonna Spitaleri lo aveva sorpreso dietro la porta della camera di Giuseppina e lo aveva cacciato rimproverandolo acerbamente e proibendogli di avvicinarsi alla porta dell’anticamera.
La nipote, alle grida, si era affacciata, mezza discinta, e le aveva domandato:
– Che cosa c’è, nonna?
– C’è che quello screanzato si fa lecito di star qui a origliare… Bisogna licenziarlo.
Giuseppina, impallidendo, le aveva risposto:
– Ha ragione, nonna. Se lo capito io, gli dirò il fatto suo.
Quella notte, non dormendo il marito in casa perché era andato a Catania, la Giuseppina, fingendo di sprangare la porta, ne aveva invece tolto i catenacci e la chiave. Fontanazza poté entrare.
– Io non verrò più – aveva detto – La vecchia potrebbe sorprenderci e io non uscirei più vivo da questa casa…
Giuseppina era diventata pallida e convulsa.
– Non verrai più? Non verrai più!… Vuoi andartene?…
– Vuoi che io sia scannato qui da tuo marito o da qualche villano?… È meglio che io mi allontani…
– E credi che io ti lasci andare?…
Allora egli le rispose:
– E perché non vieni con me? Perché non ce ne andiamo insieme? Tu sei ricca, e possiamo vivere lontani, senza soggezione…
Fu un seme gittato in un terreno fecondo: cominciò a germogliare e a metter forti radici. Sì, bisognava fuggire… Portar via tutto quel che si poteva e andarsene da quella casa, sottrarsi alla vigilanza di quella donna rigida e severa, quella sera stessa, la notte designata per la fuga.
Fontanazza aveva abbandonato la casa nella mattina, facendosi cacciare di proposito. Giuseppina aveva aspettato la notte. Aveva raccolto in un panierino i suoi gioielli. Ma la nonna ne aveva moltissimi, e di gran valore, chiusi nel suo forzieretto: erano i gioielli di tre generazioni di donne, accumulati, e che, alla sua morte, sarebbero toccati a lei, Giuseppina. Nel forziere v’erano anche dei sacchetti di doppie d’oro.
Bisognava prender tutto, quando la nonna dormiva.
– Mio marito non c’è, nonna – le aveva detto – e io ho paura questa notte a dormir sola. Verrò a dormire con lei, come quando ero piccola.
– Sì, vieni.
Così ella era entrata nella camera della vecchia.
Quando l’aveva veduta dormire profondamente, s’era levata pian piano, aveva preso le chiavi ed era andata senza far rumore ad aprire il forziere.
La lampada che ardeva dinanzi alla Madonna rischiarava la camera.
La nonna aveva il sonno leggero. Ridestata, aveva domandato, tra il sonno e la veglia:
– Chi è?
Ma nel tempo stesso, balzata dal letto, animosa com’era, e più animosa per la sua avarizia, prese un bastone. Era corsa con rapidità giovanile, nell’ombra, riconoscendola.
– Tu! tu! Che fai?…
Ella, superato il primo sgomento, aveva ributtato indietro la vecchia, che però si era messa a gridare:
– Tu mi rubi? Tu mi rubi!… Ah, trista!…
L’aveva afferrata con le mani adunche ed ossute. Ma Giuseppina, liberatasi, cieca di collera e di paura, vedendo tutto perduto, divincolandosi la buttò sul letto, minacciandola a denti serrati:
– Non gridi!… Non si muova!… O l’ammazzo!
– Ladra!… Lasciami… Ladra!… Aiuto!
Allora Giuseppina aveva afferrato un coltello e lì… nella gola, per strozzare la voce… Due colpi feroci…
Poi aveva raccolto denari e gioielli, si era buttata addosso la veste e il manto ed era uscita.
Nel silenzio della casupola, al lume fioco e rossiccio della lucerna, ora essa raccontava rapidamente come si era svolta la scena.
– Quando la nonna si mise a gridare, io non vidi più nulla… Capisci? Ero perduta, e avrei perduto per sempre te, che amo… E ho colpito… Che importa? Ora sono con te e non ti lascerò mai più!…
Per illudersi, forse, o per cancellare dai suoi occhi la tragica scena, si alzò e andò a sedersi su le ginocchia di Fontanazza, mormorandogli:
– Abbracciami!
Ma egli non l’abbracciò. Con lo sguardo smarrito, preso da una nuova paura, disse rabbrividendo:
– E se ci arresteranno, ora?
* * *
Il sole era già alto quando Giuseppina si destò. Il sonno l’aveva vinta ed ella si era addormentata sopra un mucchio di paglia e aveva dormito profondamente. Meravigliandosene, si rizzò a sedere e guardò intorno, con aria sgomenta.
Fontanazza non c’era, ma la porta del fondaco era socchiusa e dalla fessura penetrava un raggio di sole. Certo egli era uscito per governare la mula e, infatti, il sacco non c’era più su la tavola. Si levò, andò ad aprire e guardò nella stalla. La mula non c’era.
Una nube gli passò su gli occhi. Si affacciò fuori, cercò fin dove lo sguardo poteva giungere, ma invano. Dov’era Fontanazza?
Tremò, si passò la mano sulla fronte e chiamò il fondacaro che stava al beveratoio con la sua asina.
Erano otto giorni che viaggiavano per monti e valli, alla ventura, fingendosi povera gente, dormendo nei fondachi o nei conventi o qualche volta nelle capanne perdute tra feudi deserti. Ora erano capitati lì, in quel fondaco, alle falde dell’Etna, e vi avevano trascorsa la notte, dopo aver desinato in silenzio, soggiogati dalla paura. Fontanazza, infatti, aveva raccolto qualche voce sinistra. Si andava dicendo che la vecchia Spitaleri era stata assassinata a Castrogiovanni e che s’aveva la certezza che l’assassino era stato un paggio di là scacciato e che il paggio aveva avuto per complice la nipote dell’assassinata. La compagnia rurale era stata spedita sulle tracce degli assassini. Il marito della nipote aveva promesso un premio a chi porterebbe la testa della moglie e del paggio.
– Bisogna affrettarsi a guadagnare il mare – aveva detto duramente a Giuseppina – Questo ne avviene per colpa tua!… Dovevi risparmiare la vecchia!…
Poi, l’aveva fatta bere per stordirla: e per questo, forse, aveva dormito tanto…
– O voi, – domandò al fondacaro – dov’è mio marito?
Lo chiamava così, per non dare scandalo.
Il fondacaro fece un gesto con la mano, come per dire: «È andato via, lontano».
– Non vi ha detto nulla per me?
Quegli fece segno di no, col capo.
Era andato via, solo, e portato via il sacco dove erano i denari e i gioielli; l’aveva dunque abbandonata lì, senza aiuti, senza mezzi, esposta ai pericolo… Non voleva crederci, non voleva, non poteva credere a tanta viltà. Si illudeva, dicendo fra sé:
– Egli ritornerà, sarà andato a cercare il mezzo di salvarci. Stasera ritornerà.
Aspettò fino a sera, ma invano. Il fondacaro, al saperla digiuna, le offrì un boccone, ma Giuseppina non aveva fame, non poteva mandar giù nemmeno una briciola, aveva un groppo che le serrava la gola.
Ella s’era avvilita, aveva tradito, rubato, assassinato, era diventata adultera e parricida per quell’uomo; e quell’uomo ora fuggiva e l’abbandonava, sola, sperduta, perseguitata… No, una viltà simile non l’avrebbe neppure immaginata. Vigliacco! Vigliacco!…
Sentiva crescere nel suo cuore una rabbia, una voglia di vendetta che gli empiva gli occhi di lagrime ardenti Il fondacaro credette che ella piangesse di paura e di dolore.
– Povera donna! – disse.
Il domattina ella riprese il cammino… Per dove? Non sapeva dove andare, non sapeva neppure dove fosse. S’avviò alla ventura, per sentieri ignoti, domandando la carità, di un pezzo di pane, di un cantuccio in una stalla.
Sfuggendo alle insidie dei maschi bramosi. Sospinta da una necessità dominatrice e fatale. E senza saperlo si trovò nelle campagne di Castrogiovanni.
Vide da lontano, sull’alto del colle, la città col castello, con le torri nereggianti nel cielo. Lì v’era del sangue… I suoi occhi lo videro rosseggiare. E dietro il sangue vide la nonna Spitalieri, l’alta figura magra, ossuta, rigida, abbattuta sul letto, con gli occhi spalancati, la gola squarciata. Udì il grido: «Ladra!»; e poi udì un altro grido dentro di sé:
«Parricida!»; e vide e udì tutte le sue scelleratezze insorgere, gridare, schiaffeggiarla, tempestarla… Si lasciò cadere per terra. Un’ora dopo fu arrestata!
Due mesi dopo fu trasportata a Palermo e chiusa alla Vicaria.
– Sono incinta – aveva detto al capitano di Castrogiovanni, con un singhiozzo.
Ella non poteva essere toccata, né vessata, fino a che la sua maternità non si fosse compiuta. Era sacra. La spada della giustizia si fermava dinanzi all’innocente che si nascondeva nel grembo colpevole. La legge inesorabile aspettava alla porta del carcere; intanto cercava Fontanazza.
Appena arrestata essa aveva confessato ogni cosa, minutamente, senza invocar pretesti e scuse, forse anche crudelmente. Pareva che provasse un sollievo. Non aveva accusato Fontanazza, non aveva aggravato la parte di lui nel delitto; non già per un resto di passione o per generosità, ma per amor del vero: perché nessuna colpa gravasse più di quanto era giusto.
Cercavano ora Fontanazza. Tutti i capitani delle compagnie rurali, tutti i capitani di giustizia delle città e delle terre feudali erano stati avvertiti da corrieri. Avvertiti anche i portulani, per impedire che egli potesse partire.
Mandati intorno banditori che promettevano taglie. Una vera caccia battuta. La giustizia, prendendolo, non sarebbe stata inoperosa, avrebbe potuto esercitare la sua vendetta, intanto che aspettava che la parricida liberasse la vita della sua creatura.
Ella viveva nella sua cella, nella lunga agonia dell’aspettazione. La mannaia era sospesa sul suo capo. Ma più la sua maternità progrediva e più la mannaia calava. Tutte le volte che ella sentiva balzarle nel seno la creatura, pensava che era ammonimento.
– Mamma, – pareva dicesse dal mistero – io andrò alla vita e tu andrai alla morte!
Ella la sentiva quella voce. E un brivido gelato le percorreva le vene, ma non di paura, né per amor di vivere. Che gliene importava di lei? Che cosa poteva sperare dalla vita! Ella aveva sul suo capo tutte le infamie.
Ma quella creatura… Quella creatura concepita in una notte di sangue, quella creatura la cui prima cellula fu mossa dal delitto, quella creatura che non avrebbe mai conosciuta la madre e che stendeva la mano fatale nella cordicella che tratteneva la mannaia e che pur era innocente! Ah! quella creatura gonfiava il petto di un’angoscia tremenda, le accendeva smanie, la feriva di tormenti, la tempestava di tutte le passioni sommesse dall’odio e dall’amore.
Ella vedeva ogni giorno di più il suo grembo dilatarsi e non poteva arrestar quella vita nuova che le leggi irrevocabili della natura, insensibile e fatale, maturavano: la sua volontà si infrangeva contro la necessità ineluttabile. Era la sua tortura. I giudici non potevano dargliene alcuna di quelle consentite e prescritte dalla giurisprudenza criminale, perché ella era madre. Ma la natura si vendicava. La sua tortura era la più crudele, la più straziante, la più lunga.
Una notte, nei primi di marzo, ella si sgravò di un maschio. Non lo vide.
Ne udì soltanto il vagito. Lo portarono via subito, per battezzarlo alla vicina parrocchia di San Giacomo. Povero innominato, venuto al mondo in una prigione, da un’adultera e parricida, et ex ignoto patre. Quella creatura fu portata all’ospedale degli esposti. Era già orfana, prima ancora di nascere. Ormai nessuno ostacolo impediva alla giustizia di compiere il suo corso.
Giuseppina si presentò alla gran corte coi segni sul volto della recente maternità. Non si difese. Non cercò pretesti. Domandò una grazia:
– Illustrissimi, io sono rea di morte, lo so. Ve la domando, perché sarà per me una liberazione… Ma vi supplico di una grazia. Prima di entrare in cappella… fatemi baciar la mia creatura: che io possa almeno domandarle perdono d’averla messa al mondo… E di doverla abbandonare…
Ella fu rimandata. La corte s’adunò per deliberare. Il presidente era don Vincenzo Natoli, si sentiva il cuore stretto dalla pietà.
– Signori, – disse con voce commossa – ricordatevi che la condanna più che sulla colpevole cade sopra un innocente.
Ma la corte fu inesorabile e la sentenza fu di morte.
La settimana santa impedì l’esecuzione della sentenza. Il presidente Natoli ne approfitto e andò a trovare il marchese di Salinas, superiore della Compagnia dei Bianchi. Per antico privilegio la Compagnia dei Bianchi poteva ogni anno, pel venerdì santo, domandare alla gran corte la grazia per un condannato a morte.
Il superiore domandò la grazia di Giuseppina Guzzardi. La gran corte si trovò dinanzi nuovamente quel caso triste e doloroso. I giudici, il consultore volevano che la sentenza avesse tutto il suo corso. La vittima Spitaleri aspettava la vendetta, ma il presidente perorò per l’innocente.
Non v’era, dunque, sopra i codici, una legge di misericordia? Non aveva Gesù insegnato a perdonare?
I voti erano pari; quello del presidente fu per la grazia e pesò nel computo: la parricida era salva!…
Il pomeriggio del 23 marzo 1769, vestita di bianco per carità del marchese Salinas, confortata e accompagnata dal duca don Pietro Alliata, la Guzzardi uscì dalla Vicaria, con una torcia accesa in mano. Percorse la piazza Marina, dove avrebbe dovuta essere decapitata, tra una folla enorme di popolo curioso, commosso, e di cavalieri e dame in carrozza, accorsi per vedere una loro pari, in quella miseranda mostra della sua colpa.
La processione andò lenta e silenziosa. Giuseppina, pallidissima, piangeva. Non osava levar gli occhi, udiva il bisbiglio dei curiosi e qualche commento che la percoteva come uno schiaffo, e di quando in quando le sue membra avevano una scossa. Il tragitto dalla Vicaria all’Oratorio dei Bianchi le parve lunghissimo, interminabile. Ebbe i tormenti e le angosce di un supplizio.
Quando giunse all’Oratorio, le forze l’abbandonarono. Si lasciò cadere sopra un banco, scoppiando in pianto. Il marchese Salinas, che con altri confrati l’aspettava, le disse qualche parole di conforto, ma le lasciò libero sfogo al dolore.
Qualche ora dopo, il marchese Salinas condusse a casa sua, in carrozza, l’aggraziata… E a casa ella vide in una piccola culla la sua creatura…
L’innocente che aveva salvato la madre colpevole!
La notte era bella e luminosa. La luna diffondeva nel cielo un biancore che faceva impallidire le stelle e rischiarava una parte della vasta piazza silenziosa e deserta. L’arco del campanile restava immerso nell’ombra: chi vi si nascondeva non poteva esser veduto.
Il silenzio era profondo. Ma dagli orti e dai campi vicini giungeva il canto delle cicale, il trillo malinconico dei rospi. Un orologio suonò la mezzanotte.
Fontanazza rabbrividì e si guardò intorno.
No, non veniva nessuno ancora. E, per quanto egli tendesse l’orecchio, non s’udiva alcun rumore di passi.
Eppure a quell’ora tutto doveva essere avvenuto. Ella aveva promesso il colpo, verso tre ore di notte, quando tutto il palazzo si sarebbe sprofondato nel sonno. Aveva già preparato un sacco con la roba più necessaria. Non doveva che ammassare le gioie, l’argenteria e il denaro che eran nello stipo dentro la camera della vecchia… Per far questo sarebbe bastato un quarto d’ora… E intanto ne eran passati parecchi quarti d’ora… Che cosa dunque era accaduto?
Pian piano uscì dall’ombra, varcò la soglia dell’arco, scese i gradini, poi mosse alcuni passi, lenti, guardinghi, nella piazza, guardando in fondo, dalla parte dalla quale doveva venir lei; e a poco a poco attraversò la piazza, imboccò la strada buia che gli si apriva dinanzi, sempre più stupito di non veder nessuno.
Cominciava a disperare, quando udì un calpestio frettoloso che s’andava avvicinando e, indi a non molto, distinse nell’ombra una figura di donna che pareva curva sotto un peso.
La riconobbe, le mosse incontro.
La donna ebbe un gesto di sgomento e fece per fuggire, ma Fontanazza le disse:
– Son io, non aver paura… Da’ a me.
Le tolse di dosso un sacco e, ripresa la via del ritorno, soggiunse:
– Presto!… Ho nascosta la mula fuori porta Palermo.
La donna disse ansimando:
– Ma la porta sarà chiusa!…
– Non aver paura. Apriranno… Ho già disposto le cose…
Si affrettarono senza dir più nulla. Egli innanzi, lei dietro, tutta chiusa nel manto che ora, avendo libere le braccia, aveva accomodato sul capo e teneva stretto con le mani.
La porta era serrata con una grossa stanga di legno che si tirava. I gabellieri dormivano in un casotto accanto. Uno di essi si era sdraiato sopra una panchetta, accanto alla porta, e sonnecchiava. Fontanazza lo destò scotendolo e mormorandogli all’orecchio:
– Ohè, compare, aprite dunque.
– Ehm!… Siete voi? Eccomi.
La donna chiuse ancor più il manto, in modo da coprire il viso, nel passar davanti il gabelliere.
Camminarono una ventina di passi e trovarono la mula legata a un albero.
Le caricarono il sacco. Fontanazza aiutò la donna a montare in sella e, prese le redini in mano, cominciò a scendere dal colle.
La luna illuminava il vasto anfiteatro di colli e di monti che circondavano l’altipiano di Castrogiovanni e tra i quali, solitario, acuto, spiccava il monte di Calascibetta, come un gigante posto a vigilare l’antica Enna.
A mezza costa, Fontanazza prese un viottolo che si internava fra le macchie e, dopo poco, giunse a una casetta. Legò la mula a un piolo infisso nel muro. Aiutò la donna a scavalcare e, preso il sacco, entrarono.
Fontanazza accese una lucernetta preparata sopra una tavola, indi andò a sprangare la porta e, voltosi alla donna, le disse:
– Levati il manto e siedi.
Ella si lasciò cadere sopra la sedia e buttò il manto indietro. La lucerna la illuminava: era una donna d’una trentina di anni, non bella ma piacente, pallida, con una grande ruga fra le sopracciglia, un fremito nelle narici di belva, una fosca nube sugli occhi.
Fontanazza la guardò un attimo. Le vide le mani e gridò con stupore e raccapriccio:
– Del sangue? Hai del sangue nelle mani?
Allora la donna si guardò le mani aperte e le vide rosseggiare. E allora fu scossa da un brivido e una espressione di orrore alterò il suo volto.
Fontanazza ripeté:
– Del sangue!… Che hai dunque fatto?…
Ella non rispose.
– L’hai dunque uccisa?
– Sì – mormorò essa con un soffio di voce. E poco dopo aggiunse:
– Era necessario.
Rimasero un poco in silenzio, seduti, in faccia l’un dell’altro, illuminati dalla lucerna, in quella misera casupola campestre, col sacco sulla tavola.
Qualche cosa passava fra loro, invisibile ma agghiacciante. E pure avevano da tempo accarezzato il sogno di quella fuga, per vivere lontani, soli, l’uno dell’altro. Vivere della loro passione, di quella passione che aveva colmato l’abisso sociale che li separava, che aveva lacerato doveri, calpestato sentimenti e che ora tingeva fatalmente di sangue le mani di uno di loro.
Che cosa era egli, Giuseppe Fontanazza? Un paggio, un servo. Fino a quel giorno stesso egli aveva prestato i suoi servizi e, al cospetto di tutti, aveva dato dell’eccellenza alla donna che ora, a solo, trattava del tu e gli si piegava dinanzi quasi tremando. Fino a quel giorno ella, la nobile donna Giuseppina Guzzardi di Adernò, maritata a un Rametta, in Castrogiovanni, era stata per tutti la sua padrona. Da qualche mese, occultamente, era la sua amante.
Forse, in quel momento di silenzio e di terrore, la memoria si ridestava e tutto il passato, tutte le vicende della colpa ritornavano con vivace crudezza ai loro occhi interiori.
Ella non era giovane. Si avvicinava forse alla quarantina. Bruna, con gli occhi neri e cupi, la fronte bassa, la mascella forte, la bocca sensuale.
Aveva una bellezza belluina. Il suo corpo aveva la mollidezza e la flessibilità dei felini. Il suo petto pareva si offrisse.
Fontanazza era più giovane. Aveva fattezze comuni e l’aria sfrontata. Ma robusto, forte, un torello.
Ella si era accesa dalla voglia di quel torello. E una mattina che il marito era andato in campagna di buon’ora ed ella, levatasi per aiutarlo, l’aveva accompagnato fin sulla porta, come soleva fare, quando l’ebbe visto allontanarsi a cavallo, rientrò e serrò l’uscio; veduto dietro a lei Fontanazza, in maniche di camicia, col petto velloso e muscoloso, lo spinse dietro la pagliaia.
Così, Fontanazza il servo diventò il suo padrone. Egli la signoreggiò, ma era vile e aveva paura. Aveva paura del suo padrone, ma soprattutto della vecchia dama Spitaleri, la nonna di Giuseppina. Era una donna ancor vegeta e vitale, non ostante i suoi ottant’anni; con la mente lucida e i costumi rigidi. Ella teneva veramente il governo della casa. La figlia e il genero gliel’avevano lasciato. Morti essi, la nipote Giuseppina, seguendo la consuetudine, non aveva creduto di toglierle quel governo che la vecchia dama teneva così nobilmente e saviamente.
La nonna Spitaleri era sempre in giro per la casa. Dritta, segaligna, rugosa, vestita di nero alla moda della sua giovinezza, col mazzo delle chiavi alla cintola. Sorvegliava la servitù, distribuiva il pane agli uomini, il lino alle donne di casa, teneva i conti col suo razionale e segnava i crediti in pezzi di ferula, ognuno dei quali rappresentava una partita.
Oh, era inflessibile, la vecchia dama, contro gli oziosi e i sornioni.
Fontanazza lo sapeva. Una mattina la nonna Spitaleri lo aveva sorpreso dietro la porta della camera di Giuseppina e lo aveva cacciato rimproverandolo acerbamente e proibendogli di avvicinarsi alla porta dell’anticamera.
La nipote, alle grida, si era affacciata, mezza discinta, e le aveva domandato:
– Che cosa c’è, nonna?
– C’è che quello screanzato si fa lecito di star qui a origliare… Bisogna licenziarlo.
Giuseppina, impallidendo, le aveva risposto:
– Ha ragione, nonna. Se lo capito io, gli dirò il fatto suo.
Quella notte, non dormendo il marito in casa perché era andato a Catania, la Giuseppina, fingendo di sprangare la porta, ne aveva invece tolto i catenacci e la chiave. Fontanazza poté entrare.
– Io non verrò più – aveva detto – La vecchia potrebbe sorprenderci e io non uscirei più vivo da questa casa…
Giuseppina era diventata pallida e convulsa.
– Non verrai più? Non verrai più!… Vuoi andartene?…
– Vuoi che io sia scannato qui da tuo marito o da qualche villano?… È meglio che io mi allontani…
– E credi che io ti lasci andare?…
Allora egli le rispose:
– E perché non vieni con me? Perché non ce ne andiamo insieme? Tu sei ricca, e possiamo vivere lontani, senza soggezione…
Fu un seme gittato in un terreno fecondo: cominciò a germogliare e a metter forti radici. Sì, bisognava fuggire… Portar via tutto quel che si poteva e andarsene da quella casa, sottrarsi alla vigilanza di quella donna rigida e severa, quella sera stessa, la notte designata per la fuga.
Fontanazza aveva abbandonato la casa nella mattina, facendosi cacciare di proposito. Giuseppina aveva aspettato la notte. Aveva raccolto in un panierino i suoi gioielli. Ma la nonna ne aveva moltissimi, e di gran valore, chiusi nel suo forzieretto: erano i gioielli di tre generazioni di donne, accumulati, e che, alla sua morte, sarebbero toccati a lei, Giuseppina. Nel forziere v’erano anche dei sacchetti di doppie d’oro.
Bisognava prender tutto, quando la nonna dormiva.
– Mio marito non c’è, nonna – le aveva detto – e io ho paura questa notte a dormir sola. Verrò a dormire con lei, come quando ero piccola.
– Sì, vieni.
Così ella era entrata nella camera della vecchia.
Quando l’aveva veduta dormire profondamente, s’era levata pian piano, aveva preso le chiavi ed era andata senza far rumore ad aprire il forziere.
La lampada che ardeva dinanzi alla Madonna rischiarava la camera.
La nonna aveva il sonno leggero. Ridestata, aveva domandato, tra il sonno e la veglia:
– Chi è?
Ma nel tempo stesso, balzata dal letto, animosa com’era, e più animosa per la sua avarizia, prese un bastone. Era corsa con rapidità giovanile, nell’ombra, riconoscendola.
– Tu! tu! Che fai?…
Ella, superato il primo sgomento, aveva ributtato indietro la vecchia, che però si era messa a gridare:
– Tu mi rubi? Tu mi rubi!… Ah, trista!…
L’aveva afferrata con le mani adunche ed ossute. Ma Giuseppina, liberatasi, cieca di collera e di paura, vedendo tutto perduto, divincolandosi la buttò sul letto, minacciandola a denti serrati:
– Non gridi!… Non si muova!… O l’ammazzo!
– Ladra!… Lasciami… Ladra!… Aiuto!
Allora Giuseppina aveva afferrato un coltello e lì… nella gola, per strozzare la voce… Due colpi feroci…
Poi aveva raccolto denari e gioielli, si era buttata addosso la veste e il manto ed era uscita.
Nel silenzio della casupola, al lume fioco e rossiccio della lucerna, ora essa raccontava rapidamente come si era svolta la scena.
– Quando la nonna si mise a gridare, io non vidi più nulla… Capisci? Ero perduta, e avrei perduto per sempre te, che amo… E ho colpito… Che importa? Ora sono con te e non ti lascerò mai più!…
Per illudersi, forse, o per cancellare dai suoi occhi la tragica scena, si alzò e andò a sedersi su le ginocchia di Fontanazza, mormorandogli:
– Abbracciami!
Ma egli non l’abbracciò. Con lo sguardo smarrito, preso da una nuova paura, disse rabbrividendo:
– E se ci arresteranno, ora?
* * *
Il sole era già alto quando Giuseppina si destò. Il sonno l’aveva vinta ed ella si era addormentata sopra un mucchio di paglia e aveva dormito profondamente. Meravigliandosene, si rizzò a sedere e guardò intorno, con aria sgomenta.
Fontanazza non c’era, ma la porta del fondaco era socchiusa e dalla fessura penetrava un raggio di sole. Certo egli era uscito per governare la mula e, infatti, il sacco non c’era più su la tavola. Si levò, andò ad aprire e guardò nella stalla. La mula non c’era.
Una nube gli passò su gli occhi. Si affacciò fuori, cercò fin dove lo sguardo poteva giungere, ma invano. Dov’era Fontanazza?
Tremò, si passò la mano sulla fronte e chiamò il fondacaro che stava al beveratoio con la sua asina.
Erano otto giorni che viaggiavano per monti e valli, alla ventura, fingendosi povera gente, dormendo nei fondachi o nei conventi o qualche volta nelle capanne perdute tra feudi deserti. Ora erano capitati lì, in quel fondaco, alle falde dell’Etna, e vi avevano trascorsa la notte, dopo aver desinato in silenzio, soggiogati dalla paura. Fontanazza, infatti, aveva raccolto qualche voce sinistra. Si andava dicendo che la vecchia Spitaleri era stata assassinata a Castrogiovanni e che s’aveva la certezza che l’assassino era stato un paggio di là scacciato e che il paggio aveva avuto per complice la nipote dell’assassinata. La compagnia rurale era stata spedita sulle tracce degli assassini. Il marito della nipote aveva promesso un premio a chi porterebbe la testa della moglie e del paggio.
– Bisogna affrettarsi a guadagnare il mare – aveva detto duramente a Giuseppina – Questo ne avviene per colpa tua!… Dovevi risparmiare la vecchia!…
Poi, l’aveva fatta bere per stordirla: e per questo, forse, aveva dormito tanto…
– O voi, – domandò al fondacaro – dov’è mio marito?
Lo chiamava così, per non dare scandalo.
Il fondacaro fece un gesto con la mano, come per dire: «È andato via, lontano».
– Non vi ha detto nulla per me?
Quegli fece segno di no, col capo.
Era andato via, solo, e portato via il sacco dove erano i denari e i gioielli; l’aveva dunque abbandonata lì, senza aiuti, senza mezzi, esposta ai pericolo… Non voleva crederci, non voleva, non poteva credere a tanta viltà. Si illudeva, dicendo fra sé:
– Egli ritornerà, sarà andato a cercare il mezzo di salvarci. Stasera ritornerà.
Aspettò fino a sera, ma invano. Il fondacaro, al saperla digiuna, le offrì un boccone, ma Giuseppina non aveva fame, non poteva mandar giù nemmeno una briciola, aveva un groppo che le serrava la gola.
Ella s’era avvilita, aveva tradito, rubato, assassinato, era diventata adultera e parricida per quell’uomo; e quell’uomo ora fuggiva e l’abbandonava, sola, sperduta, perseguitata… No, una viltà simile non l’avrebbe neppure immaginata. Vigliacco! Vigliacco!…
Sentiva crescere nel suo cuore una rabbia, una voglia di vendetta che gli empiva gli occhi di lagrime ardenti Il fondacaro credette che ella piangesse di paura e di dolore.
– Povera donna! – disse.
Il domattina ella riprese il cammino… Per dove? Non sapeva dove andare, non sapeva neppure dove fosse. S’avviò alla ventura, per sentieri ignoti, domandando la carità, di un pezzo di pane, di un cantuccio in una stalla.
Sfuggendo alle insidie dei maschi bramosi. Sospinta da una necessità dominatrice e fatale. E senza saperlo si trovò nelle campagne di Castrogiovanni.
Vide da lontano, sull’alto del colle, la città col castello, con le torri nereggianti nel cielo. Lì v’era del sangue… I suoi occhi lo videro rosseggiare. E dietro il sangue vide la nonna Spitalieri, l’alta figura magra, ossuta, rigida, abbattuta sul letto, con gli occhi spalancati, la gola squarciata. Udì il grido: «Ladra!»; e poi udì un altro grido dentro di sé:
«Parricida!»; e vide e udì tutte le sue scelleratezze insorgere, gridare, schiaffeggiarla, tempestarla… Si lasciò cadere per terra. Un’ora dopo fu arrestata!
Due mesi dopo fu trasportata a Palermo e chiusa alla Vicaria.
– Sono incinta – aveva detto al capitano di Castrogiovanni, con un singhiozzo.
Ella non poteva essere toccata, né vessata, fino a che la sua maternità non si fosse compiuta. Era sacra. La spada della giustizia si fermava dinanzi all’innocente che si nascondeva nel grembo colpevole. La legge inesorabile aspettava alla porta del carcere; intanto cercava Fontanazza.
Appena arrestata essa aveva confessato ogni cosa, minutamente, senza invocar pretesti e scuse, forse anche crudelmente. Pareva che provasse un sollievo. Non aveva accusato Fontanazza, non aveva aggravato la parte di lui nel delitto; non già per un resto di passione o per generosità, ma per amor del vero: perché nessuna colpa gravasse più di quanto era giusto.
Cercavano ora Fontanazza. Tutti i capitani delle compagnie rurali, tutti i capitani di giustizia delle città e delle terre feudali erano stati avvertiti da corrieri. Avvertiti anche i portulani, per impedire che egli potesse partire.
Mandati intorno banditori che promettevano taglie. Una vera caccia battuta. La giustizia, prendendolo, non sarebbe stata inoperosa, avrebbe potuto esercitare la sua vendetta, intanto che aspettava che la parricida liberasse la vita della sua creatura.
Ella viveva nella sua cella, nella lunga agonia dell’aspettazione. La mannaia era sospesa sul suo capo. Ma più la sua maternità progrediva e più la mannaia calava. Tutte le volte che ella sentiva balzarle nel seno la creatura, pensava che era ammonimento.
– Mamma, – pareva dicesse dal mistero – io andrò alla vita e tu andrai alla morte!
Ella la sentiva quella voce. E un brivido gelato le percorreva le vene, ma non di paura, né per amor di vivere. Che gliene importava di lei? Che cosa poteva sperare dalla vita! Ella aveva sul suo capo tutte le infamie.
Ma quella creatura… Quella creatura concepita in una notte di sangue, quella creatura la cui prima cellula fu mossa dal delitto, quella creatura che non avrebbe mai conosciuta la madre e che stendeva la mano fatale nella cordicella che tratteneva la mannaia e che pur era innocente! Ah! quella creatura gonfiava il petto di un’angoscia tremenda, le accendeva smanie, la feriva di tormenti, la tempestava di tutte le passioni sommesse dall’odio e dall’amore.
Ella vedeva ogni giorno di più il suo grembo dilatarsi e non poteva arrestar quella vita nuova che le leggi irrevocabili della natura, insensibile e fatale, maturavano: la sua volontà si infrangeva contro la necessità ineluttabile. Era la sua tortura. I giudici non potevano dargliene alcuna di quelle consentite e prescritte dalla giurisprudenza criminale, perché ella era madre. Ma la natura si vendicava. La sua tortura era la più crudele, la più straziante, la più lunga.
Una notte, nei primi di marzo, ella si sgravò di un maschio. Non lo vide.
Ne udì soltanto il vagito. Lo portarono via subito, per battezzarlo alla vicina parrocchia di San Giacomo. Povero innominato, venuto al mondo in una prigione, da un’adultera e parricida, et ex ignoto patre. Quella creatura fu portata all’ospedale degli esposti. Era già orfana, prima ancora di nascere. Ormai nessuno ostacolo impediva alla giustizia di compiere il suo corso.
Giuseppina si presentò alla gran corte coi segni sul volto della recente maternità. Non si difese. Non cercò pretesti. Domandò una grazia:
– Illustrissimi, io sono rea di morte, lo so. Ve la domando, perché sarà per me una liberazione… Ma vi supplico di una grazia. Prima di entrare in cappella… fatemi baciar la mia creatura: che io possa almeno domandarle perdono d’averla messa al mondo… E di doverla abbandonare…
Ella fu rimandata. La corte s’adunò per deliberare. Il presidente era don Vincenzo Natoli, si sentiva il cuore stretto dalla pietà.
– Signori, – disse con voce commossa – ricordatevi che la condanna più che sulla colpevole cade sopra un innocente.
Ma la corte fu inesorabile e la sentenza fu di morte.
La settimana santa impedì l’esecuzione della sentenza. Il presidente Natoli ne approfitto e andò a trovare il marchese di Salinas, superiore della Compagnia dei Bianchi. Per antico privilegio la Compagnia dei Bianchi poteva ogni anno, pel venerdì santo, domandare alla gran corte la grazia per un condannato a morte.
Il superiore domandò la grazia di Giuseppina Guzzardi. La gran corte si trovò dinanzi nuovamente quel caso triste e doloroso. I giudici, il consultore volevano che la sentenza avesse tutto il suo corso. La vittima Spitaleri aspettava la vendetta, ma il presidente perorò per l’innocente.
Non v’era, dunque, sopra i codici, una legge di misericordia? Non aveva Gesù insegnato a perdonare?
I voti erano pari; quello del presidente fu per la grazia e pesò nel computo: la parricida era salva!…
Il pomeriggio del 23 marzo 1769, vestita di bianco per carità del marchese Salinas, confortata e accompagnata dal duca don Pietro Alliata, la Guzzardi uscì dalla Vicaria, con una torcia accesa in mano. Percorse la piazza Marina, dove avrebbe dovuta essere decapitata, tra una folla enorme di popolo curioso, commosso, e di cavalieri e dame in carrozza, accorsi per vedere una loro pari, in quella miseranda mostra della sua colpa.
La processione andò lenta e silenziosa. Giuseppina, pallidissima, piangeva. Non osava levar gli occhi, udiva il bisbiglio dei curiosi e qualche commento che la percoteva come uno schiaffo, e di quando in quando le sue membra avevano una scossa. Il tragitto dalla Vicaria all’Oratorio dei Bianchi le parve lunghissimo, interminabile. Ebbe i tormenti e le angosce di un supplizio.
Quando giunse all’Oratorio, le forze l’abbandonarono. Si lasciò cadere sopra un banco, scoppiando in pianto. Il marchese Salinas, che con altri confrati l’aspettava, le disse qualche parole di conforto, ma le lasciò libero sfogo al dolore.
Qualche ora dopo, il marchese Salinas condusse a casa sua, in carrozza, l’aggraziata… E a casa ella vide in una piccola culla la sua creatura…
L’innocente che aveva salvato la madre colpevole!
Fonte: Luigi Natoli - Storie e leggende di Sicilia
_________________

Vivere senza leggere è pericoloso, ci si deve accontentare della vita, e questo comporta notevoli rischi.
(Michel Houellebecq)
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.|
|
|